
INTERVISTA
Intervista a Veronica Vilei
Redazione On Medicine
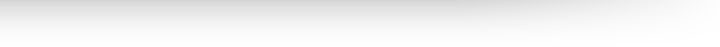
 Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, “l’educazione terapeutica dovrebbe permettere a un paziente di acquisire e mantenere capacità e competenze che lo aiutano a vivere in maniera ottimale con la sua malattia. Si tratta di un processo permanente, integrato alle cure e centrato sul paziente che implica attività organizzate di sensibilizzazione, informazione, apprendimento dell’autogestione e sostegno psicologico concernente la malattia e il suo trattamento”. Questo concetto fondamentale trova nella malattia diabetica un campo ottimale di applicazione; la dottoressa Vilei, specialista in Endocrinologia e malattie del ricambio presso l’Ospedale di Seregno (ASST Brianza), ci racconta come da anni lo mette in pratica con i propri pazienti.
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, “l’educazione terapeutica dovrebbe permettere a un paziente di acquisire e mantenere capacità e competenze che lo aiutano a vivere in maniera ottimale con la sua malattia. Si tratta di un processo permanente, integrato alle cure e centrato sul paziente che implica attività organizzate di sensibilizzazione, informazione, apprendimento dell’autogestione e sostegno psicologico concernente la malattia e il suo trattamento”. Questo concetto fondamentale trova nella malattia diabetica un campo ottimale di applicazione; la dottoressa Vilei, specialista in Endocrinologia e malattie del ricambio presso l’Ospedale di Seregno (ASST Brianza), ci racconta come da anni lo mette in pratica con i propri pazienti.
Dottoressa Vilei, come si svolge la sua attività professionale?
Sono dirigente medico e lavoro prevalentemente presso l’ambulatorio di diabetologia dell’ospedale di Seregno, che gestisce pazienti affetti da diabete sia di tipo 1 sia di tipo 2. Seguiamo anche pazienti borderline, con una glicemia ancora non diagnostica per diabete ma per i quali è fondamentale la terapia dietetico comportamentale perché è quella che permette eventualmente di procastinare o addirittura evitare l’insorgenza della patologia.
Questi pazienti che ancora non sono da avviare al trattamento farmacologico sono consapevoli del problema e dei rischi a cui possono andare incontro?
Esistono due tipologie diverse di pazienti: quelli che hanno paura di dover iniziare la terapia farmacologica, e che di conseguenza impostano una terapia dietetico comportamentale rigida, e quelli che invece non percepiscono il problema come reale e quindi ne sottostimano il rischio. La percezione della malattia è molto soggettiva.
I pazienti che vengono inviati al vostro ambulatorio sono stati adeguatamente informati in precedenza sulle conseguenze del diabete?
Secondo me no. Alcuni hanno una storia familiare di diabete complicato, per esempio un genitore in dialisi o che ha subíto delle amputazioni, e quindi hanno paura di dover affrontare gli stessi problemi; altri non hanno una percezione dei rischi a cui potrebbero andare in contro sottovalutando la patologia. Le informazioni trasmesse ai pazienti sull’argomento variano in funzione del medico che li ha in cura. Va detto, però, che molti pazienti che non vanno mai dal dottore, e sono spesso i più giovani che devono lavorare, non hanno tempo e quindi sottostimano i sintomi. Spesso arrivano da noi con un esordio di malattia importante, con glicemie già molto alte.
I pazienti inviati al vostro ambulatorio rimangono poi in gestione da voi?
Dipende; personalmente penso che abbia molto senso tenere in carico i pazienti giovani e seguirli nei primi anni dopo la diagnosi; i pazienti anziani, una volta stabilizzati, si possono rimandare al Medico di Medicina Generale anche per poter consentire nuovi ingressi (abbiamo in carico circa 3000 pazienti). Il paziente giovane ha bisogno di essere preso in carico perché il diabete, a meno che sia scompensato, soprattutto all'esordio non dà segni di sé; il paziente si sente bene e quindi magari per anni non si cura e non fa esami perché ha altre priorità, quindi è meno concentrato su se stesso. Questo succede più difficilmente nell'anziano, soprattutto se è in pensione. Il nostro ruolo di “controllori” ha quindi più senso nel paziente giovane piuttosto che nell'anziano.
Come Centro adottate delle delle strategie comuni da mettere in atto per rendere più consapevoli questi pazienti dell'importanza dello stile di vita?
Direi di no. Ogni medico fa un po’ quello che ritiene più opportuno. Non abbiamo nulla di codificato perché i pazienti sono tanti, quindi pensare di organizzare delle delle attività di gruppo è difficile. Cerchiamo di dare un minimo di consapevolezza e facciamo fare degli esami intermedi di controllo per avere la conferma che le cose stanno andando bene. Il paziente sa che se gli esami non vanno bene possono venire da noi anche senza appuntamento per fare una puntualizzazione della terapia.
E per quanto riguarda i pazienti giovani, che come ci diceva prima meritano un’attenzione particolare?
Per i pazienti più giovani affetti da diabete di tipo 1 organizziamo una volta ogni tanto degli incontri formativi con approfondimenti a cura di un relatore; organizziamo anche delle trasferte, come passeggiate in montagna o giri in bicicletta, durante le quali i ragazzi hanno la possibilità di confrontarsi tra loro e svolgere attività di gruppo. L'anno scorso, per esempio, abbiamo fatto una passeggiata in Val di Mello e cenato in un rifugio; per venire incontro alle necessità e agli impegni di lavoro di tutti ci siamo trovati di venerdì pomeriggio alle quattro e siamo tornati al punto di partenza a notte inoltrata, usando le torce. Un’altra volta abbiamo organizzato il giro del lago di Garlate in bicicletta. Sono esperienze che servono molto, alle quali alcuni sono già abituati perché quando sono in pediatria partecipano a campus specificamente organizzati; poi però, con la transizione a centro che si occupano degli adulti perdono quest’opportunità. Inoltre, dato che l’esordio del diabete tipo 1 a 30 anni è sempre più frequente, ognuno impara a gestire il proprio diabete in modo diverso: c'è chi ha il sensore, chi ha il microinfusore, chi usa le penne; quindi il confronto è sempre un'esperienza importante.
-
Farmacologia clinica dei farmaci anticoagulanti
Marco Moia Centro Emofilia e Trombosi - Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano
-
Sintomi del basso apparato urinario dopo chirurgia pelvica: fisiopatologia e trattamento
Enrico Finazzi Agrò - Professore Associato; Cattedra di Urologia, Università di Roma “Tor Vergata”; UOSD Servizio di Urologia Funzionale, Policlinico Tor Vergata; IRCCS Ospedale S. Lucia, Roma
-
Fisiologia di apprendimento e memoria
Mariano Pedetti - SerT MVT, AUSL2 dell‘Umbria, Marsciano (PG)


