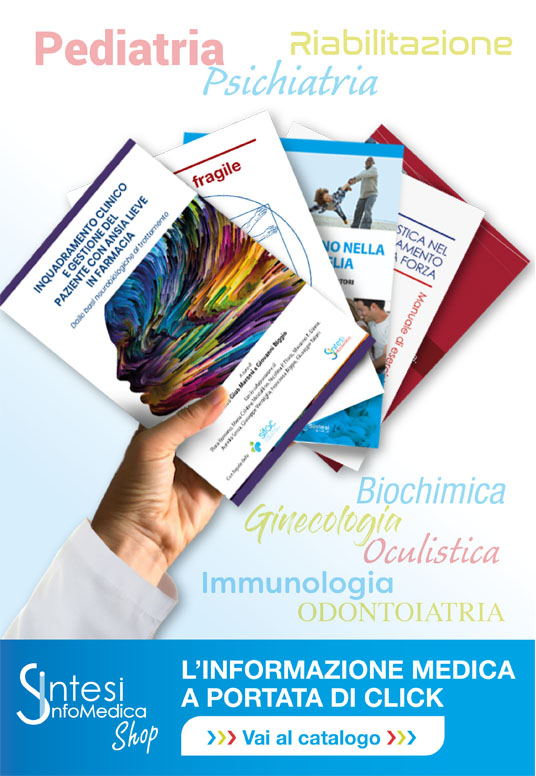INTERVISTA
Intervista a Marco Manoni
Redazione On Medicine
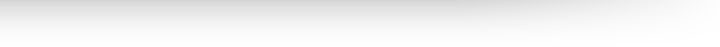
 Le terapie avanzate sono il futuro della medicina e l’Italia ha da sempre un ruolo fondamentale nella ricerca e sviluppo in questo ambito; infatti, tra le prime terapie autorizzate dall’EMA ben 4 derivano dalla ricerca italiana. Un esempio di questo successo è la terapia genica ex-vivo approvata per l’ADA-SCID, una forma di grave immunodeficienza genetica. Al momento nel mondo ci sono più di 1900 studi clinici dedicati a queste terapie. Per far luce su questo peculiare argomento è significativa l’esperienza del dottor Marco Manoni, biologo e biotecnologo.
Le terapie avanzate sono il futuro della medicina e l’Italia ha da sempre un ruolo fondamentale nella ricerca e sviluppo in questo ambito; infatti, tra le prime terapie autorizzate dall’EMA ben 4 derivano dalla ricerca italiana. Un esempio di questo successo è la terapia genica ex-vivo approvata per l’ADA-SCID, una forma di grave immunodeficienza genetica. Al momento nel mondo ci sono più di 1900 studi clinici dedicati a queste terapie. Per far luce su questo peculiare argomento è significativa l’esperienza del dottor Marco Manoni, biologo e biotecnologo.
Dottor Manoni, qual è stato il percorso che l’ha condotto alle terapie avanzate?
Sono prima di tutto un biologo e un biotecnologo; ho iniziato la mia carriera di ricercatore all’Istituto di Tecnologie Biomediche Avanzate (ITBA) che era appena nato, e nel frattempo ho preso la prima specializzazione nata nel campo delle biotecnologie. Ai tempi ancora non si sapeva bene cosa volesse dire questo termine, e da qui è nato il mio interesse che mi ha prima portato al Consiglio Nazionale delle Ricerche, dove ho potuto conoscere il prof. Dulbecco, premio Nobel per la medicina, che ha promosso e guidato il progetto Genoma umano italiano per la mappatura e il sequenziamento del genoma umano, per poi passare al San Raffaele per dedicarmi al trasferimento tecnologico.
Sono quindi passato all’industria Biofarmaceutica, dove ho svolto il ruolo di direttore scientifico e direttore di vari reparti di ricerca e sviluppo dedicandomi principalmente alle biotecnologie applicate allo sviluppo di derivati di microrganismi e batteri. Dopo un ritorno al San Raffaele come direttore operativo di una della prima società italiana
nel campo delle terapie cellulari e geniche, spin-off dello stesso Istituto, nella quale ho avuto modo di collaborare allo sviluppo ed industrializzazione delle prime due terapie geniche approvate a livello internazionale, mi sono dedicato alla consulenza in questi ambiti, dedicandomi al trasferimento tecnologico, ovvero alla realizzazione e organizzazione delle Cell factories (le “fabbriche di cellule”) e all’industrializzazione e applicazione di tecnologie automatiche per la produzione di terapie cellulari e geniche.
Ci può spiegare meglio la sua attività?
La mia attività principale è gestire e aiutare a sviluppare la fase intermedia, ovvero portare la ricerca di base, quindi le nuove terapie che escono dalla fase di ricerca, alla clinica. In questa fase mi occupo del trasferimento sia di tecnologie che aiutino a incrementare le dimensioni del lotto, sia all'applicazione stessa delle tecniche per poter industrializzare il prodotto e, quindi, diminuire i tempi e i costi di produzione per renderlo disponibile ai pazienti. Il mio ruolo non è soltanto tecnico, ma anche gestionale nell’ambito delle officine farmaceutiche per l’autorizzazione alla produzione di terapie avanzate, e regolatoria, ambito altamente disciplinato a livello sia nazionale che internazionale.
Quali sono le principali difficoltà che si trova a dover affrontare?
Questi prodotti seguono ovviamente una regolamentazione strettissima e devono essere preparati in condizioni rigorosamente controllate; consideriamo che non parliamo di un prodotto farmaceutico come una molecola di sintesi, che può per esempio essere sterilizzata termicamente alla fine del procedimento, ma di prodotti di origine biologica, quindi cellule, DNA o RNA che non possono, ovviamente, essere sterilizzati. La difficoltà dell’industrializzazione di questi procedimenti è, quindi, realizzare sistemi che permettano di mantenere la qualità e l’asetticità in tutte le fasi del processo sin dall'inizio, in modo tale che si arrivi a un prodotto finale completamente sterile che verrà somministrato al paziente.
Uno dei metodi di somministrazione di queste terapie prevede l’utilizzo di virus: non è rischioso?
No. Partiamo dal presupposto che sono diversi i vettori virali utilizzati, i principali sono derivati da retrovirus e lentivirus; che normalmente vengono utilizzati nelle terapie ex vivo: dove vengono cioè, prelevate le cellule del paziente, trasformate in laboratorio tramite questi vettori virali e quindi reiniettate nello stesso paziente. I vettori virali utilizzati sono resi innocui: sono ottenuti dal virus da cui vengono eliminate tutte le sequenze patogene e di replicazione, che vengono sostituite con le sequenze del gene attivo che si vuole introdurre.
Il virus iniettato come sa dove andare a inserire le sequenze geniche che veicola?
Oltre ai trattamenti “ex vivo” i vettori virali possono essere somministrarti direttamente per via sistemica “in vivo”. Il vettore virale in questo caso va a legarsi a specifici recettori di superficie che vengono espressi dalle cellule; grazie a ciò il vettore si dirige e si localizza principalmente nel tessuto che si vuole trattare.
Oltre a possedere dei segnali specifici forniti dai propri antigeni che ne determinano il loro tropismo, i vettori virali possono essere iniettati direttamente in loco, per avere una maggiore efficacia e disponibilità nel tessuto o organo bersaglio. Per esempio, sono in via di sviluppo terapie e tecnologie geniche che hanno come target alcune patologie oculari specifiche come la retinite pigmentosa, la sindrome di Usher e la malattia di Stargardt.
Vettori virali molto utilizzati per queste terapie sono derivati dal Virus adeno-associato (AAV). Almeno una decina di sierotipi possono essere attualmente utilizzati nella terapia genica e ognuno di questi ha un diverso e preferenziale target tissutale.
La speranza è che si possa ampliare progressivamente l’applicazione di queste tecnologie per renderle sempre più efficaci, sicure, disponibili ed economiche per il trattamento non solo delle malattie genetiche, malattie rare e complesse condizioni degenerative croniche, ma anche di tumori e di malattie autoimmuni.
-
Farmacologia clinica dei farmaci anticoagulanti
Marco Moia Centro Emofilia e Trombosi - Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano
-
Sintomi del basso apparato urinario dopo chirurgia pelvica: fisiopatologia e trattamento
Enrico Finazzi Agrò - Professore Associato; Cattedra di Urologia, Università di Roma “Tor Vergata”; UOSD Servizio di Urologia Funzionale, Policlinico Tor Vergata; IRCCS Ospedale S. Lucia, Roma
-
Fisiologia di apprendimento e memoria
Mariano Pedetti - SerT MVT, AUSL2 dell‘Umbria, Marsciano (PG)